mode
N.08 Febbraio 2020
Definizioni
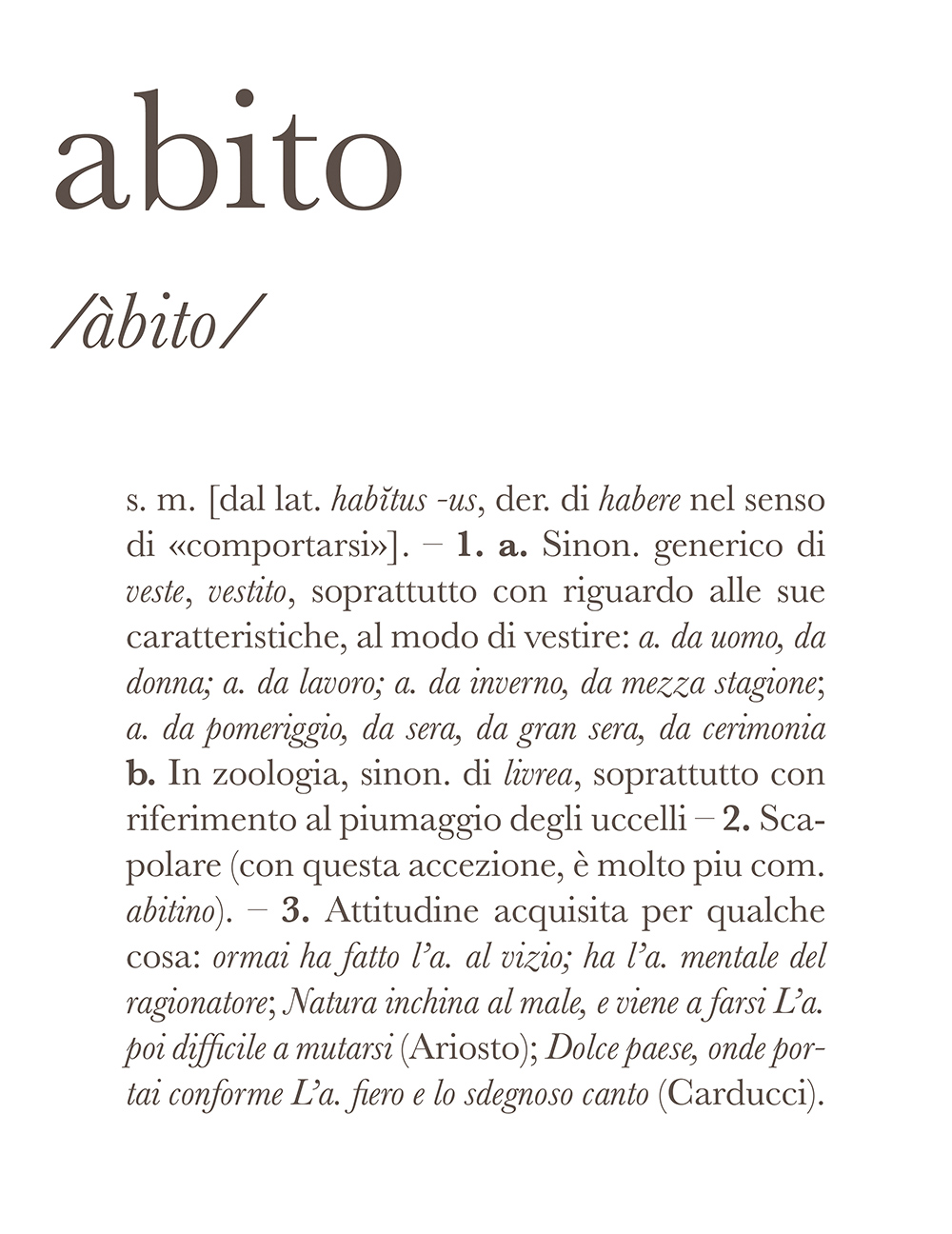

«Il più bell’abito che può abbigliare una donna sono le braccia dell’uomo che ama. Ma, per chi non ha la possibilità di trovare questa felicità, io sono qui». Trovo sempre bella e attuale questa frase di Yves Saint Laurent, stilista indimenticato a cui la moda deve tanto. L’abito è molto più di un semplice pezzo tessuto, è un qualcosa che ci copre, ci ripara, ci scalda e ci nasconde. È questa la funzione principale a cui, stagione dopo stagione, si è aggiunta un’estrema cura e ricercatezza di tessuti, lavorazioni e decorazioni che spesso rendono l’abito un oggetto del desiderio. Esiste una psicologia della moda secondo cui, attraverso la forma di un abito, i suoi colori, l’ampiezza, la stampa o i suoi movimenti, si può trovare la chiave di lettura alla conoscenza di noi stessi. Certo è che, nell’epoca moderna, ci si sta allontanando dall’essenza dell’abito, cioè quella di avvolgere: il proprio look si mette in pasto sui social network, diventa oggetto di lavoro – come per le influencer – e spesso non si sceglie nemmeno più cosa indossare ma ci si muove solo per spirito di massa. «Compro quest’ abito perché l’ho visto addosso a…»: quante volte ho sentito questa frase. E un po’, ve lo dico: mi ha anche stufato. Un abito ha sempre dato la possibilità di voler mostrare quello che ci piace, quello che siamo, e non si merita di finire nel calderone degli oggetti inflazionati e poi dimenticati. Ecco perché, nel mondo frenetico di oggi, mi piace tornare all’immagine più pura di quel pezzo di stoffa che ci fa sentire al sicuro. Come un abbraccio.
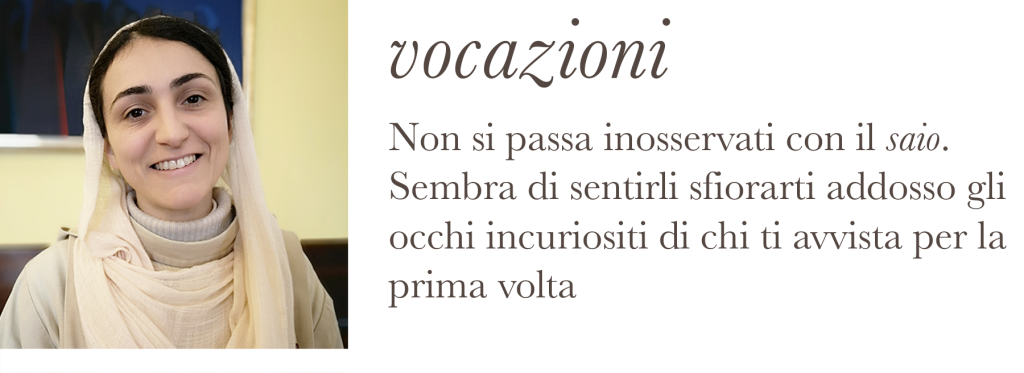
L’abito non fa il monaco (o la monaca), si dice. Certo un religioso non è tale per l’abito che indossa, ma provate ad immaginare un uccello che va in giro svestito del suo bel piumaggio colorato. Svanita parte della sua bellezza, non riuscirebbe facilmente a spiccare il volo!
Fu un fraticello povero, fin dal nome emblematicamente comunicativo, fra Volantino, ad ideare il “saio” che indosso e ad usare questa immagine per spiegare l’importanza che l’abito religioso (letteralmente) riveste nell’annuncio della buona notizia. La stessa particolare scelta del colore ha chiaramente un suo senso preciso: il beige richiama il colore del “sacco” evangelico, segno visibile di conversione e radicale cambiamento interiore (Lc 10,13).
Il saio che “abito” quotidianamente è ormai quasi “una seconda pelle”, ciò che immediatamente mi (rap)presenta, chiede di veicolare il ricordo dell’Altro e silenzioso anticipa e prepara l’annuncio verbale. Non si passa inosservati con il saio. Sembra di sentirli sfiorarti addosso gli occhi incuriositi di chi ti avvista per la prima volta, iniziando a scrutare con accuratezza tutti i particolari: oltre il colore insolito e la trama grezza della stoffa, il cordone con i tre nodi, i sandali ai piedi, la borsetta laterale sempre color sacco e il grosso rosario al fianco destro. I frati poi tagliano i capelli a forma di corona e le suore indossano uno strano velo che lascia intravedere la capigliatura. La voglia di capire e di andare più in profondità ha spesso la meglio anche sulla timidezza e così quel semplice e superficiale galleggiante colorato, per usare un’altra espressione cara al nostro fondatore, attira tanti pesci nella grande rete dell’evangelizzazione.
Una confezione con tanto di etichetta scritta a caratteri cubitali e indicante ciò che dovrebbe trovarsi dentro. Ovviamente tutto si gioca in ultimo al di là del pezzo di stoffa che ricopre quasi interamente la superficie del corpo, in quello che la filosofia classica chiamava habitus, una disposizione non innata ma consapevolmente acquisita, divenuta col tempo quasi “una seconda natura”, che porta il virtuoso a compiere determinate (buone) azioni in modo reiterato e costante.
L’abito rappresenta, dunque, il primo signum visibile di un linguaggio muto e al contempo eloquente che attrae o respinge, ma difficilmente lascia indifferenti. “A” come “abito” vuole essere allora una iniziale d’impatto nell’alfabeto dell’annuncio!

Cosa può rappresentare la maglia azzurra per un bambino? È come chiedersi cosa rappresenta un sogno in un mondo di realisti. È gioia, è speranza, è il motivo che ti spinge ad alzarti al mattino.
Quando ero bambina mi ricordo che un giorno era entrato in palestra un Olimpico di canottaggio. Uno di quelli che la maglia azzurra la veste nel cuore, ancor prima che sulla pelle, e che gli traspare dagli occhi.
Prima che entrasse era già cambiato tutto: il clima era teso, carico di aspettativa, tutti più attenti per farsi trovare pronti, nel miglior assetto possibile quando lui avrebbe varcato la porta.
E poi eccolo. Statuario, muscoloso, possente… ma più di tutto fiero. L’abbiamo visto lavorare quel giorno e – credetemi – la fatica la sentiva come ogni essere umano. Ma nemmeno in una palata l’ho visto risparmiarsi o lamentarsi o pentirsi.
Glielo si leggeva negli occhi che viveva per un sogno, che aveva fatto del suo sogno una solida verità: la sua vita. E ci avrebbe dedicato l’anima, non importa quanta fatica gli costasse.
Quella volta ho capito che indossare quella maglia è un onore e una responsabilità: ti contraddistingue come guerriero.
Lo vedi subito insomma, uno vestito con la maglia sportiva. Magari nemmeno la indossa, ma se chiudi gli occhi gliela puoi vedere.
Ecco, io vorrei vestire quella maglia, nelle palestre e nella mia vita. Vorrei che quando passo la gente che mi vede possa dire «si vede che veste la maglia azzurra, è una guerriera, ce l’ha nel sangue».
