parole
N.24 Ottobre 2021
«Mettiamo in circolo parole nuove contro la grammatica del sospetto»
Dialogo con Isabella Guanzini filosofa e teologa cremonese che dopo il saggio sulla tenerezza è in libreria con la "Filosofia della gioia"
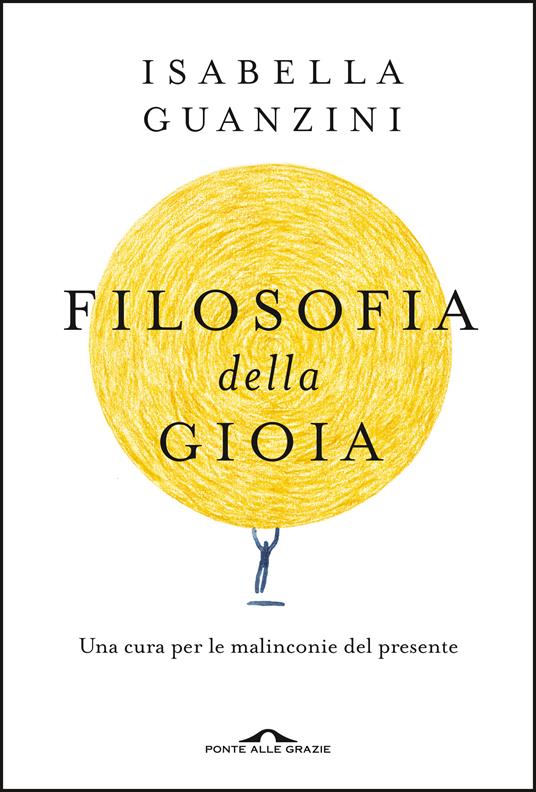
IL LIBRO
La gioia è mistero, incanto, oscillazione. È l’azzardo che ci porta ad abbracciare l’incertezza, rischiando ciò che non abbiamo. È il contrario del cinismo e della paura. L’antidoto alla stanchezza. In queste pagine, Isabella Guanzini ci guida alla ricerca del senso che la sfrenata accelerazione e poi l’improvviso arresto del mondo hanno strappato, appannato, spento. E ci racconta che, per rinascere, per restituire ritmo ai corpi e ai cuori, non ci è richiesta alcuna forza sovrumana e nemmeno una particolare propensione. Perché, come dice Lacan, «in ciascuno di noi è tracciatala via per un eroe, ed è da uomo comune che la si percorre».
La parola che usa più spesso in questo periodo è “gioia”. Un paradosso nella stagione di stanchezza, cinismo e paura che stiamo vivendo? No, un gesto politico, una provocazione, un’impresa non per smidollati, ma per persone coraggiose. La filosofa e teologa cremonese Isabella Guanzini, professoressa e ricercatrice all’Università di Linz, mamma di un bimbo di tre anni, ci racconta di sé e del suo ultimo libro “Filosofia della gioia”, scritto durante i lockdown austriaci, della nuova grammatica emotiva che restituisce ritmo ai corpi e ai cuori, delle parole “che contano” e della Parola che ci dice come “avere vita in abbondanza”.
Partiamo dal libro “Filosofia della gioia”. Com’è nato?
«È nato con un sentimento di protesta nei confronti di una situazione di melanconia, di separazione e di inquietudine che anche il tempo della pandemia ha generato. Con il desiderio di superarla. Ho sentito l’esigenza di reagire ad un senso di tristezza e di angoscia diffuse e di mettere a tema una parola che è poi un’esperienza di cui oggi si fa fatica a parlare perché veniamo da un periodo drammatico di mortificazione generale. Personalmente, è stato anche un mio modo per elaborare ciò che abbiamo vissuto, per portare nella scrittura anche le mie angosce».
Cos’è per lei la gioia?
«La gioia non è mai esperienza di esaltazione, di spontaneità, di mera leggerezza. La gioia è l’effetto di una conquista, di un percorso, di un cammino anche molto faticoso. È la luce alla fine di un tunnel, la gioia della nascita di un bambino dopo un travaglio, la gioia della Pasqua dopo la passione. Per me la gioia ha a che fare con il passaggio attraverso il buio, attraverso il trauma».
Nel libro, c’è la parola che chiude e che si contrappone alla meraviglia e alla scoperta, tipiche dei bambini. Ma c’è anche la parola che da forma al caos per essere qualcosa di veramente umano. Che ruolo hanno le parole?
«Le parole hanno un ruolo definitivo, non nel senso di chiusura, ma nel senso di necessario. Senza le parole non abbiamo la possibilità di vivere dentro il trauma e di superarlo. Ci permettono di reggere la fatica. Il silenzio dentro il trauma è difficilmente sopportabile. Le parola degli uomini e anche la parola biblica nasce per dare forma al caos, senza però dominarlo del tutto. Resta sempre una zona opaca che emerge: questa è la vita, la bellezza della vita. Per questo continuiamo a parlare… La parola è il principio fondamentale di umanizzazione della vita, fa in modo che non sia lasciata all’orrore della violenza e del trauma».
Altra parola chiave per lei è tenerezza, su cui ha scritto un altro libro di successo. C’è relazione tra gioia e tenerezza?
«Certo. Entrambe le parole sono difficilmente pronunciabili oggi. La tenerezza è una sorta di contropotere, una provocazione nei confronti delle esigenze della società odierna della prestazione, della competizione, della durezza nei confronti della vita e di se stessi. Sulla gioia giace un’ipoteca. Chi parla della gioia oggi rischia di essere considerato ingenuo o patetico. Diciamo che entrambe le parole hanno accettato la sfida di dire qualcosa di diverso. Di reagire, di compiere un gesto di resilienza e di speranza».
Ci sono altre parole significative, emblematiche, care per la sua vita?
«Da qualche anno, una parola importante per me è “infanzia”. Infanzia è la speranza di poter creare del nuovo, vuol dire avere la capacità di rinascere ogni volta, di iniziare sempre tutto da capo. Un bambino deve ripetere sempre la stessa cosa e ogni volta è un’esperienza diversa. Ogni bambino che viene al mondo è la promessa di un nuovo inizio. Benché l’infante etimologicamente sia colui che non può parlare, siamo in un momento in cui dobbiamo imparare a parlare non sui bambini o ai bambini, ma con i bambini, considerandoli capaci di parola, una parola diversa ma piena di nuove possibilità per noi».
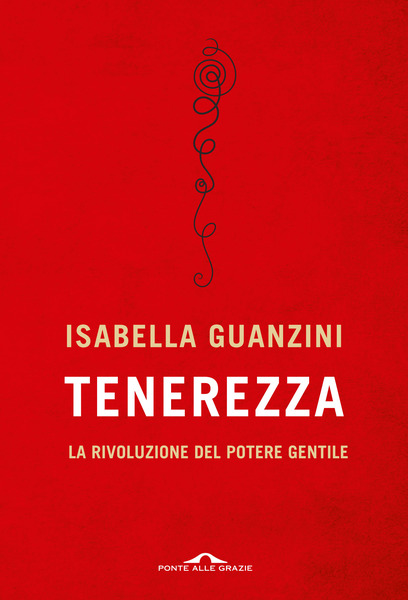
Tenerezza. La rivoluzione del potere gentile
La tenerezza, quando è autentica, non sopporta facili definizioni: si insinua con delicata tenacia tra le grandi virtù civili e la retorica del potere, è ciò che ci manca per poter vivere e sentire in un mondo finalmente comune. Per questo parlarne è un’impresa ardua e bellissima. E tanto più importante, oggi, quanto più la realtà, nella sua opaca pesantezza, si rende indecifrabile, narcisistica, violenta e sentimentale al tempo stesso.
A proposito di infanzia, il gioco è un’esperienza molto presente dei suoi libri…
«Mi interessa molto questo aspetto dell’infanzia: il gioco inteso come nuovo uso delle cose e delle parole che i bambini mettono in atto. C’è l’idea che la realtà non sia esattamente fissabile e definitiva, ma che attraverso il gioco possano emergere nuove possibilità. Ciò che si può fare delle cose è molto di più di ciò che le cose sono».
Preferisce i verbi o i sostantivi?
«Direi i verbi, anche se nei titoli dei miei libri ci sono sostantivi. Il verbo è il movimento, dice di un’azione. È qualcosa di dinamico, che deve essere messo in atto, che può modificare le cose e si può modificare. Mette in moto. Ha una potenza transitiva e intransitiva. Purché il verbo sia bello, certo…».
Parola filosofica e parola poetica sono spesso accostate nei suoi scritti. Che rapporto c’è?
«La parola filosofica deve sempre essere interrotta dalla parola poetica e viceversa. La parola filosofica tende di natura alla definizione, all’argomentazione, al pensiero oggettivo, a dire le cose per quella che è la loro essenza. L’intrusione della poesia è sana perché dice alla filosofia che le nozioni non sono ultimative, che la potenza del logos talvolta è impotente nei confronti delle esperienze fondamentali dell’esistenza, come il desiderio, la verità, Dio, il senso, il futuro, la gioia. Da una parte c’è il concetto che è come un setaccio steso sul mondo, che cerca di fare ordine sul caos; dall’altra occorre abitare poeticamente il mondo per cogliere delle risonanze che al setaccio del concetto sfuggono, ciò che altrimenti non si riuscirebbe a dire».
Lei lavora con le parole. Che rapporto ha con le parole?
«Un rapporto appassionato, ma difficile. Io non insegno e non scrivo praticamente mai nella mia lingua. Per me le parole quindi sono come in esilio. Sono in una condizione di perpetua traduzione. Da una parte mi sento spaesata perché vivo spesso l’esperienza quotidiana di non dire in tedesco o in inglese esattamente quello che direi nella mia lingua. Nello stesso tempo è una grande sfida che mi arricchisce: essere sempre in qualche modo distaccata dalla mia identità, che è anche identità linguistica, è un’esperienza importante. È come se, per capire davvero la produttività delle parole, io debba abbandonare la mia sicurezza e la mia abitudine. Nel momento in cui cerco di tradurre capisco il significato profondo delle parole. Ciò ha molto a che fare con l’esistenza: sentirsi spaesati per capire ciò che si è».
Ci sono eventi nella vita delle persone che possono far cambiare le parole, intese come significato alle cose?
«Penso alla maternità che è un’esperienza in cui davvero per la prima volta c’è dell’altro, qualcun altro che richiede, esige di essere nominato. E questo nome diventa un tuo secondo nome che ti accompagna per sempre. È una gioia non priva di angoscia, sempre un po’ velata da paure, responsabilità e preoccupazioni. Una gioia che non è mai spensierata e leggera, che si conquista e si trasforma, e proprio per questo è vera».
Un’esperienza, la maternità, che possono fare solo le madri?
«Cosa significa essere madre lo può comprendere chi ha un rapporto di formazione, di accompagnamento, di creazione della realtà. Un musicista nei confronti della propria musica, un artigiano nei confronti di ciò che plasma. Chi ha la fortuna, la grazia di avere dei momenti nella vita in cui si sente in contatto con la propria potenza, con la potenza di esistere, capisce cosa significa mettere al mondo. Si è materni e generativi nel momento in cui si lotta per restare in contatto con questo desiderio».
Come fa la società ad acquisire una “nuova grammatica emotiva”?
«In questa pandemia sono emersi nuovi significanti: pandemia, distanza sociale, vaccino, infezione, lockdown. C’erano già queste parole ma non erano iscritte nel nostro modo di vivere e pensare. C’è un nuovo vocabolario sociale che si è iscritto nel corpo sociale. Questa nuova grammatica ha trasformato la società in una società del sospetto in cui regnano nuove paure. La sfida quindi è rimettere in circolo nuove parole come gioia, tenerezza, fiducia, speranza, iscrivere nel corpo sociale queste parole attraverso gesti di cura, di produzione creativa di spazi e tempi, attraverso discorsi nuovi».
Quale possibile ruolo della Parola, quella fatta carne, nella cura delle malinconie del presente?
«Rispetto a questo direi due cose. La prima: la Bibbia, soprattutto nel primo Testamento, ha conosciuto una trasformazione del suo vocabolario. All’inizio ci sono parole anche molto dure, molto violente. Poi, la grammatica della Parola si modifica, espelle la violenza, emergono parole della misericordia. Questo accade attraverso l’esilio del popolo che rappresenta il momento del trauma. È il dramma che ha generato un nuovo modo di parlare. Questo dice molto anche sul momento che stiamo vivendo».
La seconda?
«Nella Parola troviamo le parole. Non c’è esperienza umana, soprattutto affettiva, che nella Bibbia non trovi una sua elaborazione, che non diventi una domanda per l’uomo. Con le dovute ricontestualizzazioni, troviamo una riserva di parole e di racconti che davvero ancora, ancora di più, ci dicono come diventare più umani, non solo come sopravvivere ma come avere la vita in abbondanza. Questa è la fede nella Parola».
