terra
N.01 Maggio 2019
Definizioni

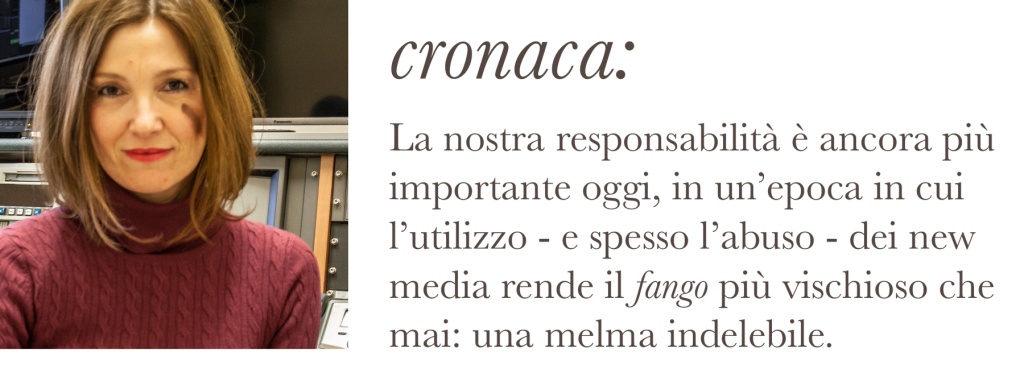
“Quando guardi a lungo l’abisso, l’abisso guarda dentro te”. E un giornalista, nell’abisso, ci si trova spesso. Faccia a faccia con la violenza, a tu per tu con la ferocia umana, davanti al muro del destino ingiusto. Ho trascorso molti anni ad essere una cronista di nera (dove il verbo “essere” non è usato a caso), a scrivere di morti ammazzati, di rapine, di droga, di prostituzione, di incidenti stradali finiti in tragedia. Ne ho scritto cercando, sempre, di farlo in modo distaccato: descrivendo la realtà, non vivendola; ma ammetto che, a volte, la tentazione di andare oltre la cronaca, oltre i fatti, l’ho avuta. Bastava una sola parola, per farlo. Per sbattere in prima pagina un altro “mostro” che poi magari si sarebbe scoperto innocente; per trasformare un’altra vittima in carnefice anche solo a causa di un pruriginoso sospetto, assecondando un’atmosfera, seguendo l’onda di un’opinione pubblica famelica, diventando parte dell’abisso.
Ai giornalisti non è concesso, però: per deontologia professionale, per “forma mentis”. Perché varcare quel confine significa lasciarsi contaminare, sporcarsi le mani con il fango.
Chi ha il privilegio di esercitare questo meraviglioso mestiere ha l’obbligo morale e professionale di mantenere ad ogni costo il controllo: vietato lasciarsi travolgere dalla macchina che gira. Perché le parole non possono e non devono diventare schizzi che sporcano la vita degli altri.
E la nostra responsabilità è ancora più importante oggi, in un’epoca in cui l’utilizzo – e spesso l’abuso – dei new media rende il fango più vischioso che mai: una melma indelebile. È questa la nuova sfida: la verità senza il fango, i fatti oltre la melma. È la stessa ragione d’essere del giornalismo, del ruolo fondamentale che ha l’informazione.
Ecco, mi piace pensare che i giornalisti siano questo: professionisti con i piedi nel fango, ma con gli occhi e il cuore capaci di guardare lontano. Oltre la palude.

Bella fatica, però, prendersela col fango. Tutti a denigrarlo per via dei suoi schizzi, temutissimi fisici o metaforici che siano. Non nego che avere a che fare con lui comporti i suoi bravi problemi, anche perché è un tipo che si affeziona, ti si attacca e levartelo di dosso è – alla lettera – un bucato, che si tratti delle tue scarpe o della tua reputazione. Eppure sì, io mi sento di spendere due parole positive sul suo conto, a fargli da avvocato d’ufficio in questo processo a senso unico.
Ora, da un po’ ci si è persi di vista, ci si frequenta saltuariamente. Ma da bambino e ancora da ragazzo, oh sì che me la sono spassata in sua compagnia. Trovarlo era una festa, che fosse in riva al mare per fare castelli o piste per le biglie di plastica con le immagini dei corridori, impossibili da fare con la sabbia asciutta, o all’oratorio quando dopo un acquazzone si tornava a dare calci al pallone; e che battaglie epiche quando la palla si fermava in una pozzanghera. Il difficile veniva poi, a casa, quando si tentava invano di spiegare alla mamma quanto era più divertente giocare sul bagnato, e insomma il fango non meritava di finire nell’elenco delle cattive compagnie da evitare.
Poi da ragazzo l’atletica, secondo amore, e la corsa campestre vera passione, col fango complice di un divertimento impossibile da spiegare a chi non lo condivide. E, solo da spettatore, il rugby, altro sport che nel fango si esalta fino a farne poesia epica. Adesso come ho accennato ci si rivede di rado, e confesso qualche volta cerco di evitarlo. Ma non è lui che è diventato cattivo, sono io che divento vecchio.
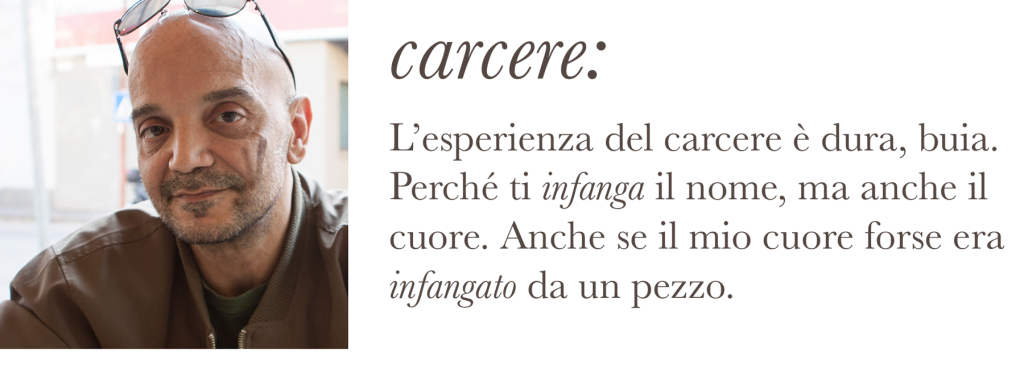
Mi chiamo Michele, ho 46 anni e la mia vita non è mai stata semplice. Ma in fondo credo che nessuna vita sia “semplice”, perché a tutti accadono fatti e incontri che sconvolgono l’esistenza. A me ne sono successi di brutti ma anche di belli. Non ho mai conosciuto mio padre, non so chi sia. Mia madre mi ha cresciuto insieme a un compagno dal quale ha avuto mio fratello, ma i momenti più belli e felici io li ho vissuti con i nonni e frequentando l’oratorio. Ero un ragazzo sensibile ma problematico: fumavo di nascosto e non riuscivo a togliermi dalla testa la domanda insistente su chi fosse il mio vero papà. Mia mamma taceva e io soffrivo. Quando avevo circa vent’anni, la situazione in casa divenne insostenibile e lei mi cacciò. Finii a lavorare per dei giostrai: per cinque anni ho fatto la vita da nomade, accompagnandoli in giro per il mondo aggiustando giostre. Poi decisi di tornare, perché mia madre si era ammalata. Furono anni duri: dovevo lavorare per mantenere lei, il compagno e mio fratello. Finché un giorno un incidente in moto cambiò tutto. Rimasi in coma per 20 giorni e al mio risveglio la prima cosa che vidi fu un grande crocifisso in ospedale. Sembrava dirmi “Sei ancora qui, fai qualcosa di buono e di utile”. Ma non è sempre facile tenere la strada dritta.
Negli anni finii a rubare auto per campare e con le auto rubate facevo il taxista abusivo nei night. Finché non mi beccarono e finii in carcere a Cremona. L’esperienza del carcere è dura, buia. Perché ti infanga il nome, ma anche il cuore. Anche se il mio cuore forse era infangato da un pezzo. Ma proprio dietro le sbarre ho incontrato degli amici che mi hanno cambiato la vita. Paolo, Agazio, Susanna sono solo alcuni dei loro nomi: venivano a fare volontariato, per stare con noi carcerati. È nata un’amicizia grande perché loro mi hanno fatto vedere che la vita può davvero essere bella e non è mai troppo tardi per ricominciare.
Una volta uscito dal carcere, ho cominciato a stare con loro: ho conosciuto famiglie con tanti bambini, gente che è felice di passare insieme le giornate, che si impegna nel lavoro, nella vita della Chiesa e della società o nell’educazione dei figli senza tanti discorsi ma con tanta gioia. Così ho iniziato a seguirli. Oggi ho un lavoro che mi piace e che – ironia della sorte – è in un lavaggio-auto.
L’unico “fango” che mi ritrovo addosso è quello del grasso delle auto a fine turno. E sono felice.
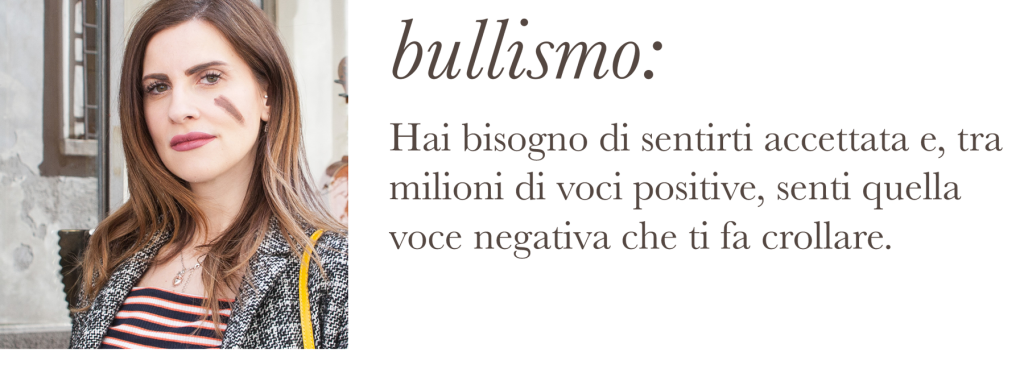
Qualche tempo fa, una persona a cui voglio ancora molto bene, mi disse che ero una donna forte e, se ero riuscita a superare il mio passato, poteva succedermi qualsiasi cosa ma l’avrei superata sempre. Mi disse che avevo le mie figlie e il mio blog e non mi sarebbe servito nient’altro.
Al momento, ricordo che pensai fossero le solite frasi di circostanza che si dicono per occupare il silenzio. Io ero vittima delle mie convinzioni e vedevo solo quelle. Si creano come un vortice, per il quale hai bisogno di sentirti accettata dagli altri per accettare te stessa e, tra milioni di voci positive, senti quella voce negativa che ti fa crollare.
Ho reso pubblica la mia storia di bullismo e mi ha fatto molto male
parlarne, ma poi ho capito che non potevo continuare a guardarmi indietro e dovevo uscire dal fango di quella situazione e fare in modo che quelli che credevo fallimenti diventassero esperienze, racconti che potessero dimostrare agli altri che, se ci credi davvero, puoi farcela. E che è vero: quando puoi superare l’umiliazione una volta diventi una guerriera e niente può più scalfirti. Credo che quella persona volesse dire questo. Comunque sia, io ora vedo un messaggio positivo in tutto.

Sporcarsi le mani e non solo. Questa è la sfida più grande del diventare educatore. Dire di “essere un educatore” è sempre una frase che mi fa tremare i polsi; più da sussurrare a se stessi, che da affermare ad alta voce perché mette davanti agli occhi le tue fragilità e i limiti delle tue azioni. Sporcarsi le mani e non solo significa ascoltare tanto, anche le cose che danno fastidio, spremere la parte più buona di sé per dire una parola utile a qualcuno, aprire gli occhi sulle cose dolorose e saper guardare la realtà com’è adesso immaginando come potrebbe diventare. Significa stare nella relazione e fare delle cose che a volte non servono a niente se non a passare del tempo con le persone. Educare significa accompagnare una persona che sceglie di darti fiducia, accompagnarla su strade che non scegli, ma che sceglie lei: asfaltate, sterrate, fangose, allagate, sbarrate, buie per poi magari tornare indietro o aprirne di nuove. Sporcarsi le mani e non solo, come un bambino che si butta nel mondo senza paura di sporcarsi i vestiti, sporcarsi le mani e non solo, come un artigiano o un artista che si prende cura del grezzo per generare bellezza.
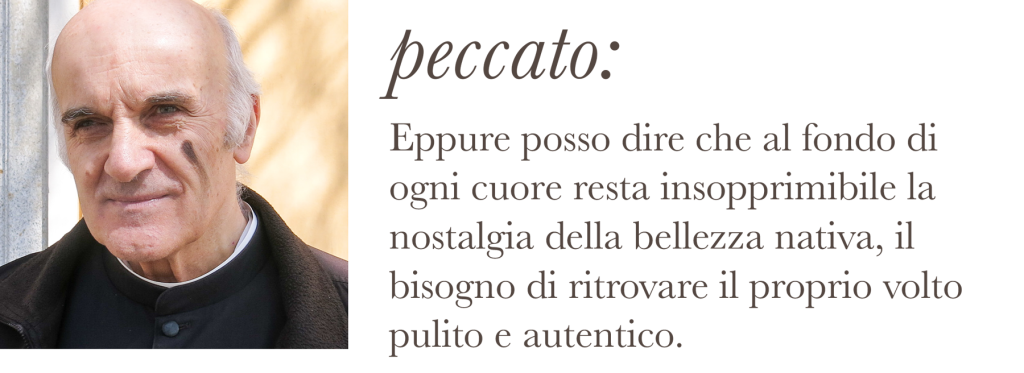
È un termine utilizzato anche come metafora per indicare tutto ciò che può sporcare e abbrutire la persona e la sua vita, per dire cioé qualcosa che è male.
Ho colto spesso in confessionale espressioni come queste: “Sono caduto nel fango, vivo nel fango, hanno infangato la mia vita…”
Parole come queste dicono la grande amarezza di dover constatare quanto si è caduti in basso e quanto sia opprimente il male compiuto; dicono la consapevolezza di aver profanato la propria dignità e la propria esistenza; dicono talvolta la rassegnazione molto triste di fronte al proprio degrado, che appare ormai inarrestabile; gridano anche il risentimento per il male ricevuto da altri e del quale si è costretti a portare le conseguenze.
Soprattutto esprimono il senso d’impotenza davanti a quella forza che trascina al ribasso e alla corruzione e che si insinua in ogni piega della vita personale, familiare e sociale.
Mi ricordo la domanda disperata di un uomo travolto dai propri sbagli e dalla cattiveria di altre persone: «Ma allora il male vince sempre in questo mondo?».
Il fango c’è e può sfigurare le persone e la vita. Di fronte ad esso molti vivono in uno stato di ribellione rabbiosa permanente, altri invece si trascinano in una sorta di avvilimento inattivo e lamentoso.
Eppure posso dire che al fondo di ogni cuore, anche quello più guastato dal male e dalle sue conseguenze, resta insopprimibile la nostalgia della bellezza nativa, il bisogno di ritrovare il proprio volto pulito e autentico, la memoria profonda e struggente di un mondo che c’era e che deve venire, un mondo nel quale ci si guarda l’un l’altro senza farsi del male. Mi viene in mente spesso l’immagine di un uomo coperto di detriti e di ciarpame di ogni genere che protende energicamente le braccia verso il cielo con le mani spalancate.
Dopo la confessione una donna mi chiese: «Adesso posso sentirmi bella come quando ero una ragazza ed ero felice?».
